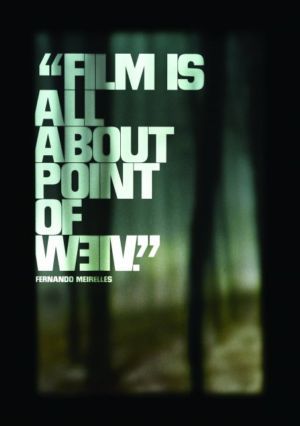DA LONDRA – “Uno dei Festival più importanti del mondo”, recita il catalogo distribuito dal British Film Institute che lo promuove (insieme ad altri festival, alla gestione della storica rivista Sight&Sound, alla spettacolarità del gigantesco IMAX e a un’imprescindibile biblioteca-archivio, in aggiunta a proiezioni ed eventi quotidiani). Alzando gli occhi dalla pagina, però, appare chiaro che i conti non tornano. Il London Film Festival (15 – 30 ottobre) c’è, ma è invisibile agli occhi indaffarati della metropoli che lo accoglie. E piuttosto sfocato anche a guardarlo dall’estero. Schiacciato tra Venezia, Toronto e la neonata, flebile concorrenza romana, l’evento londinese ha le dimensioni e la caratura del festival importante, ma sembra diluirle in una volontaria attitudine distaccata.
Votato alla dimensione popolare e alle aspirazioni da finestra sul mondo degli altri Festival, raccogliendo il meglio dell’annata per consegnarlo alla visione domestica (attitudine particolarmente british), il Festival di Londra stupisce per il contrasto tra la sua potenzialità e la tiepida accoglienza che gli viene riservata, all’estero ma soprattutto dalla stessa stampa londinese. Una suggestiva spiegazione l’ho trovata nelle parole di un affabile giornalista locale: “Hai idea di quanti Festival si organizzano ogni anno a Londra? Questo è solo uno dei tanti, in ogni momento qui c’è la possibilità di assistere a una manifestazione sul cinema africano, o sudamericano, o russo”. Il Festival ci piace, ma è uno dei tanti e deve mettersi in fila, dunque. Eppure non è una spiegazione soddisfacente di fronte a una manifestazione che guadagna in prestigio anno dopo anno, e che dà tutta l’impressione di poter essere lei, ben presto, a schiacciare i Festival che la circondano, primo fra tutti quello di Roma, sempre più vaso di coccio dopo la sua terza edizione. I numeri sono enormi: più di 300 film tra lungometraggi e corti, 40 paesi rappresentati, 15 giorni di festival. Il perfezionamento di una struttura che è al tempo stesso consolidata e fresca sulla scena internazionale. L’idiosincrasia tutta britannica nei confronti dell’idea festivaliera si spiega, oltre che con il citato sovraffollamento della capitale, anche con una certa storica insofferenza per quello che un Festival rappresenta, perlomeno nella sua accezione europea. La storia del pensiero inglese è puntellata di un garbato sospetto nei riguardi dell’autorialità, e i maggiori Festival del continente, come Cannes e Venezia, dell’autorialità sono simboli. Non solo rappresentano un lato glamour dell’esposizione cinematografica – tra cerimonie e lustrini – che l’austera tradizione inglese tende ad evitare, ma incarnano l’idea di autore che dalla metà dello scorso secolo è diventata prassi nella teoria filmica.
Avendo sentore che gli addetti ai lavori collegassero questo discorso a una vera e propria assenza di tradizione cinematografica nazionale, ho provato a far presente che la storia inglese non è esattamente povera di prestigio e grandi nomi. Eppure secondo loro un piccolo scarto rimane, e il “loro” Festival non potrà mai essere come gli altri, proprio per questo. La concezione pragmatica e in un certo senso utilitaristica che lo governa va anche oltre quella di altri festival non competitivi, in cui non c’è una sezione concorso e non ci sono premi in palio, come il sempre più importante Toronto Film Festival.
La bontà dell’edizione di quest’anno si misura dunque sulla panoramica dei titoli presentati. Tra i nomi principali, sicuramente quello di W., ritratto bushiano di Oliver Stone scippato a Roma, con tanto di coda polemico-politica sul clima della manifestazione capitolina. A conferma della sostanziale indifferenza che circonda Londra, almeno in Italia, c’è il fatto che in molti ricordino la presenza di W. al Torino Film Festival di Moretti, dimenticandosi della prima londinese con più di un mese in anticipo.
La sezione Gala contiene anche l’elefantiaco Che di Soderbergh, diviso in due parti e caratterizzato dalla monumentale interpretazione di Benicio Del Toro. Viene da Cannes, così come la Palma d’Oro La classe. Il robusto elenco di pellicole facilmente commerciabili e di prevedibile buon successo nei prossimi mesi (Easy virtue, condiviso con Roma e Toronto, The brothers Gloom, The Other man, Genova di Winterbottom, dramma ambientato in Italia che avrebbe dovuto essere a Venezia) fa volume intorno a scelte mirate e di gran prestigio: Frost/Nixon è opera di un Ron Howard meno howardiano del solito, e racconta il confronto televisivo tra Nixon e un giornalista inglese non esattamente di alto profilo, all’indomani dello scandalo Watergate. Un film su cui gli organizzatori hanno puntato molto, piazzandolo in apertura. Forse perché è il prodotto più equilibrato di tutto il lotto, per certi versi il più sicuro. Gradevole, ben scritto e con ottimi spunti di commedia.
Alla sua ombra la sezione Gala ha collocato anche progetti più coraggiosi e meno visibili, come il controverso Hunger (sul tema sensibile dell’IRA) e Waltz with Bashir, documentario animato di grande spessore, non solo per la forma scelta. D’obbligo anche l’anteprima, svaporata dall’imminente uscita, del nuovo Bond, Quantum of Solace. Per non parlare dell’ultimo Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, che seppur malriuscito e già visto in molte sale europee (comprese quelle italiane) è sempre un nome ben spendibile.
Una line-up impressionante, se si considera che era soltanto la superficie patinata. Un secondo livello è costituito dalla sezione Film on the Square, che raccoglie il meglio della stagione. Da segnalare il mastodontico A Christmas Tale, opera di Arnaud Desplechin. Affresco familiare dal respiro epico e imponente, ottimo contraltare del minimalismo di Demme in Rachel getting married. Visti insieme, sono un efficace trattato sul diverso potere del detto e del non detto. Uno si trattiene, l’altro si riversa esageratamente. Da tenere d’occhio quando arriverà in Italia. Questa sezione contiene inoltre il vero best of degli altri Festival: Kitano, Zhangke, Kaufman, i Dardenne, Gray, Spike Lee, Uli Edel con La banda Baader Meinhof, visto pochi giorni fa anche a Roma; c’è anche Ozpetek con Un giorno perfetto e Moretti è venuto per Caos Calmo.
Il film italiano che ha riscosso maggiori consensi, con l’eccezione del piccolo Sono viva, piaciuto agli inglesi e ancora senza distribuzione in Italia, è stato però Il Divo di Sorrentino. Separato dal suo “parente” Gomorra, uscito in Inghilterra proprio a ridosso del Festival con una distribuzione di tutto rispetto, il film su Andreotti è passato quasi sotto silenzio in questi giorni londinesi, nonostante sia stato acquistato da Artificial Eye per gennaio. Inevitabilmente si è perso di vista nel mare magnum londinese, ed è stato mostrato alla stampa a inizio ottobre quando il clima era ben lontano dallo scaldarsi. Tuttavia, chi lo ha visto non lo ha dimenticato.
Complice una quasi totale assenza di informazioni – che gli inglesi non lo ricordassero da Cannes è ulteriore testimonianza delle diversità culturali già menzionate – il film ha potuto contare sull’effetto sorpresa, e chi credeva di trovarsi di fronte a un blando e descrittivo biopic politico è stato travolto dall’opulenza sorrentiniana. Il limite intrinseco de Il Divo, evidente fin da Cannes, è ovviamente la sua ardua comprensibilità per l’audience straniera: i volti perplessi e affannati di fronte al rapidissimo Glossario Italiano che compare in apertura erano eloquenti.
Ma la brusca accelerazione che Sorrentino imprime alla storia nella seconda metà viene esaltata dalle difficoltà interpretative. Ironicamente, le brevi scene che costellano qua e là la prima parte di film, con i pentiti trasportati in macchina e aereo, come a stringere d’assedio il protagonista, acquistano nuovo senso perché prefigurano la valanga di informazioni narrative dell’ultima parte, già soverchiante di per sè, ma totale quando di quel periodo e della nostra storia non si sa nulla. Nelle inquadrature di Sorrentino in cui anche la tappezzeria offre densità visiva, con i pentiti che mitragliano nomi e connessioni, e le didascalie che identificano i personaggi, i pur volenterosi giornalisti inglesi sperimentano una curiosa forma di confusione cognitiva.
Peccato non si sia fatto di più, anche a causa di un materiale stampa molto scarno (quello de La banda Baader Meinhof conteneva un compendio di cinque pagine di date, nomi ed eventi utili per contestualizzare). L’assoluto valore del film fa comunque ben sperare per gennaio.
 Il Festival di Londra non si ferma certo a due sezioni. C’è quella sul cinema francese e un’altra sulle migliori nuove proposte del cinema britannico (docilmente integrata con un profilo globale: Alemanno e Rondi potrebbero prendere spunto). Tra queste un buon successo potrebbe averlo Awaydays, che dipinge una plumbea Liverpool thatcheriana e post-punk, con un gusto alla Shane Meadows ancora più attento alle suggestioni musicali e del look dell’epoca.
Il Festival di Londra non si ferma certo a due sezioni. C’è quella sul cinema francese e un’altra sulle migliori nuove proposte del cinema britannico (docilmente integrata con un profilo globale: Alemanno e Rondi potrebbero prendere spunto). Tra queste un buon successo potrebbe averlo Awaydays, che dipinge una plumbea Liverpool thatcheriana e post-punk, con un gusto alla Shane Meadows ancora più attento alle suggestioni musicali e del look dell’epoca.
Come se non fossero già ampiamente rappresentati, ci sono anche due sezioni specifiche sul World Cinema e Cinema Europa. In quest’ultima si trova di tutto, dal blockbuster bellico danese al piccolo caso italiano degli ultimi mesi, Pranzo di Ferragosto. Anche il Vicari di Il passato è una terra straniera ha trovato spazio in contemporanea alla presenza romana.
Tutto questo nella placida e compatta sede del BFI Southbank, stretta tra il Royal National Theatre e il National Film Theatre e affacciata sul Tamigi. Quando c’è da fare sul serio, però, l’arena di Leicester Square con i suoi cinema imponenti prende il sopravvento. E il pubblico risponde in modo entusiastico, saccheggiando queste sezioni, ma anche tutte le altre (quella sui corti, quella sulle avanguardie, i tesori degli archivi…). Sintomo di un mercato sano, florido, che proprio per questo si diluisce nel suo più grande asset, la città di Londra. Che per ora è talmente indaffarata da oscurare il suo Festival. Per ora.