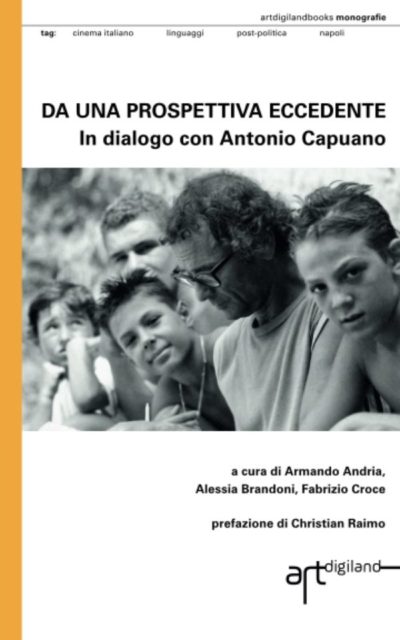Diciamocelo, era necessario un libro che cercasse di monitorare l’eccedenza della figura di Antonio Capuano nel panorama italiano: da quel 1991 in cui Vito e gli altri anticipava i fermenti che solo negli anni seguenti sarebbero maturati per sbocciare in un nuovo cinema napoletano e non solo; a questo 2022 in cui grazie all’omaggio resogli dall’allievo Paolo Sorrentino in È stata la mano di Dio Capuano è assurto a figura semi-mitologica, ma in contemporanea a quello status si sottrae con un nuovo film, Il buco in testa, che come sempre si inserisce perfettamente nel suo opus, e perfettamente scarta di lato, con una di quelle finte creative che sono, alla fine, il suo tratto distintivo par excellence.
Il libro di Andria/Brandoni/Croce,scritto su e con Capuano, è maturato intorno a un’estesa, frantumata intervista in cui nel corso del tempo il regista ha dato fondo alle proprie emozioni e incazzature, coordinate artistiche e meridiani esistenziali. Gli autori hanno riplasmato il materiale “entropico e recalcitrante” dei colloqui, che comunque hanno deragliato il programma originale del volume, buttando all’aria qualsiasi pretesa di esposizione ordinata e strettamente cronologica. Il ricorso alla voce dell’oggetto/soggetto indagato – costante dei volumi artDigiland – produce un organismo critico vivente, respirante e spiazzante, contagiato dalla trascinante verve capuanesca: una verve che sgrana frammenti di vita posillipese del regista da guaglione e da magnifico ottantenne sempre aduso alle sue droghe partenopee (nuotate e caffè) e parlando d’altro delinea con nonchalance la sua poetica (parola che senza dubbio gli puzzerebbe): “Questo mi affascina: il piccolo, l’infinitesimale … Però io ancora non ci sono arrivato e non ci arriverò mai a questo piccolo che contiene tutti i cazzi.”
Il piacere vitale (corporeo) dei suoi film, che filtra anche la disperazione, emerge dal dialogo, come il suo approccio architettonico – del resto ha iniziato come scenografo nella Rai anni Settanta. Il tracimante bisogno di comunicazione si aggancia alla sovversione linguistica di un’anima modernista; l’ascolto dei luoghi, della luce, a un nucleo forte di narratore, un narratore consapevole della crisi della narrazione ma ostinato a reinventare modi di fare cinema dal/col caos, senza mai ricopiarsi, anche quando ha la sensazione di fare sempre la stessa cosa. La vitalità sfrenata che riesce a cogliere e coreografare nei suoi piani sequenza circolari o nei montaggi spezzati è il filo rosso di una filmografia anarchica e barocca, capace di smarcare tutte le aspettative, spettacolari e spettatoriali, con estremi come la tragedia stilizzata di Luna rossa e la farsa surreale di Achille Tarallo: “La vita è sempre la cosa più forte, cosa c’è più della vita?”
Arrivano alla spicciolata le sue ispirazioni: Van Gogh e Francis Bacon, Brecht e Beckett, Godard ed Herzog; emerge il suo divertimento sul set (che “appartiene sempre alla muscolatura, al respiro, al sudore, al sangue”), la sua pittura segreta; si delinea una figura di regista inteso come “segugio” del cambiamento, che a fiuto contamina violenza e bellezza; di un artista con propositi utopici, assoluti: “Io vorrei che potessimo vedere tutto contemporaneamente…”Gli aggettivi usati dagli autori per descrivere il loro approccio tendono a sovrapporre lo sguardo “obliquo” dell’autore a una conseguente trasversalità d’indagine. E infatti, ecco che dopo il tuffo nel mare Capuano, arrivano gli approfondimenti saggistici: Alessia Brandoni si applica a un originale découpage scena per scena di Vito e gli altri che squaderna le sue considerazioni critiche seguendo passo passo lo svolgersi del clamoroso esordio, riuscendo a coglierne nel vivo le scelte espressive (le soggettive, i ritornanti piani sequenza circolari) e i nuclei ideali (le lacune, la simultaneità, gli straniamenti). Fabrizio Croce si concentra sul successivo Pianese Nunzio, 14 anni a maggio, scegliendo agli estremi le chiavi dell’amore pasoliniano e del Genet reinterpretato da Sartre per schiudere le barocche ferite sacre e profane, di “anima e carne” del rapporto tra Don Lorenzo e il ragazzino eponimo, in una dialettica serrata e problematizzante. Armando Andria infine analizza l’ossessione del tempo, il presente “della violenza brutale e non premeditata di Vito”, “il passato come possibilità di storicizzare” all’inizio rigettato da Capuano, il tempo che “sembra di fatto svanire” in Luna rossa, per poi riconquistare il centro della scena colto nella possibilità di cambiamento dei film successivi, con la tarda scoperta linguistica del flashback.