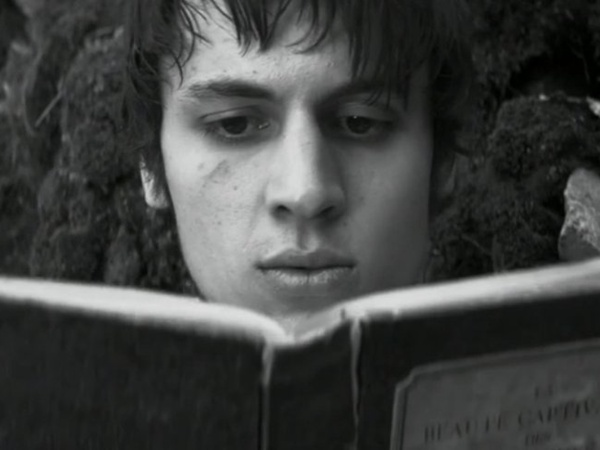di Fabrizio Funtò/ Sembrerà strano, ma lo spettatore al cinema rispetta ancora le tre regole aristoteliche dell’unità: unità di luogo, di tempo e di racconto.
Entri nella grotta platonica della sala cinematografica, e te ne stai seduto in silenzio per un paio d’ore, e poi esci. L’atto è concluso.
In quel tempo dato, il regista ed il produttore devono riuscire a immergerti (e a farti riemergere) in un complesso mondo che deriva solitamente da un romanzo o da una sceneggiatura che ha al suo interno uno degli elementi fondamentali della narrazione moderna: lo sviluppo del carattere dei personaggi.
Ora, una buona parte del cinema sensazionalistico ha virato sui “supereroi”, proprio perché la loro posizione nel continuum psicologico evolutivo è inchiodata dal loro essere bipolari. Da una parte un omuncolo insignificante (Clark Kent, Peter Parker, ma anche Bruce Wayne etc.) che sono identità posticce della cui evoluzione psicologica non importa niente a nessuno, proprio perché si tratta di un “incognito”, un anonimo” ― e dall’altra Superman, Spiderman, Batman della cui evoluzione psicologica, ancora una volta, non importa niente a nessuno. Perché sono “alter”.
Ma, passata la sbornia suprematista, ad Hollywood si saranno detti che occorre ritornare al buon vecchio film, alla sceneggiatura stratificata. Alla bravura, alla perizia, al talento di un regista che deve condensare in immagini sincretiche quella sottilissima linea d’ombra sul cui crinale corrono i testi narrativi che ne costituiscono la base concettuale. Ed il crinale, in questo caso, è tutto.
Cito un autore come Roman Polanski. Se pensate al “Pianista” ― con Adrien Brody quasi soffocato dal suo stesso personaggio ― oppure a quel magistrale quartetto da camera di “Carnage” (poi ripreso benissimo dall’italiano “Dobbiamo parlare”), che tiene inchiodati sulla poltroncina oscurata per ore, sul filo di un prodigioso dialogo in caduta libera, capite bene cosa io intenda.
Però, nella storia di una espressione artistica, i fatti costituiscono delle pietre. Non sempre “miliari”. L’evoluzione dei supereroi, lo si vede lontano un miglio, è costituita dalla sessione interattiva. Non penso solo ai videogame, ma piuttosto ad una forma espressiva del cinema totalmente nuova, molto immersiva, molto virtuale, dove ad esempio (cito) se vedi terminator che sale su una macchina e va via, oppure Doc che apre la DeLorean e sta per partire, tu ci puoi saltare dentro (muovendo il punto di vista) e farti portare da quella evoluzione narrativa. E quindi potrai vivere dentro lo spazio chiuso del racconto cinematografico in modo nuovo, diverso, coinvolgente. Un futuro forse neanche troppo lontano.
Nel quale prevale lo spazio degli effetti visivi sul tempo dell’evoluzione dei personaggi.
Questo filone sposa il cinema con le tecnologie e con i parchi a tema. Una possibile evoluzione le cui basi sono tangibili già oggi.
Piccola nota personale. Mi è capitato di lavorare per anni per il gigante dei videogiochi, Activision, e appena si annunciava un nuovo film di supereroi, ma perfino di “007”, iniziava subito la conta per chiarire a quale degli Studios sarebbe toccato di fare il game… e veniva considerata una piccola roulette russa.
L’evoluzione dall’altro filone in cui si è scissa la produzione cinematografica sembra essere invece la “serie” televisiva. Vale a dire un film lungo, lunghissimo, basato su sette, otto, o su una stagione intera di puntate, che recupera la dimensione narrativa, la fruizione intermittente tipica del romanzo storico, contravvenendo quindi definitivamente alle tre unità aristoteliche che menzionavamo all’inizio. E consentendo al team di direzione del progetto di staccare il tubo poetico ed attaccare quello narrativo, a metro lungo.
Il personaggio principale, il suo Villain antagonista, la corte dell’uno e dell’altro, i terzi che costituiscono l’”accidens”, l’imprevisto, la deriva laterale: hanno tutti tempo per evolvere. E se una stagione non basta, ce n’è sempre una successiva.
Gli autori più bravi (e qui fioccano i grandissimi nomi di Hollywood, nessuno escluso) o se volete i più “cinematografici” fra di loro, si concentrano in genere nelle “Mini-serie”, sequenza di veri e propri film, mai più di sette o otto, che finalmente possono raccontare al pubblico i piccoli spostamenti psicologici, le piccole evoluzioni del personaggi, gli smottamenti, le crisi e le riprese, che hanno costituito per oltre due secoli la caratteristica fondamentale del romanzo educativo e di introspezione.
E lo si sente subito: l’immedesimazione con “il” o “la” protagonista è fortissima, l’evoluzione psicologica viene introiettata con potenza e insieme con raffinatezza. I personaggi non sono in grande numero, come per le serie lunghe. Il lavoro di scrittura è intensionale, e proprio per questo non può essere portato oltre una certa soglia emotiva limite.
Le serie a stagioni successive invece hanno bisogno non solo di un gran numero di personaggi, in modo tale che ciascuno ritrovi la propria configurazione emotiva nel personaggio affine e nel simile, ma disgraziatamente anche di interventi del “deus ex-machina”, a cui ricorrono inevitabilmente prima o poi, deragliando.
La storia in genere nasce nella prima stagione realistica, plausibile e radicata in fatti; si sviluppa per una seconda o una terza stagione in modo coerente. Ma poi, esaurita la spinta propulsiva, analizzate le combinazioni e gli intrecci possibili, nella ripetitività dei cliché interviene la magia, il soprannaturale, il divino, i morti che ritornano ― denunciando palesemente il fine commerciale del prodotto.
Ma le mini-serie no, costituiscono un’altra cosa: un lungo film (come a volta faceva nel suo Heimat Edgar Reitz) suddiviso in capitoli, retti tutti da una strettissima unità di concetto e dispiegati lungo quel famoso crinale di analisi dell’evoluzione dei personaggi, che richiede appunto un tempo più lungo della fruizione cinematografica tradizionale.
Sir Anthony Hopkins ne è risultato folgorato, tanto da aver preso carta e penna ed aver scritto una lettera ammirata e sperticata a Bryan Craston di “Breaking Bad”. Saltando quindi anche lui su questo carro.
Lui, che probabilmente è oggi il miglior attore cinematografico al mondo.
Se il cinema vola come una farfalla innamorata dell’estate verso questi nuovi e promettenti lidi, il suo battito d’ali provoca invece una catastrofe nell’altra parte del mondo della letteratura.
Il cinema sugge linfa vitale dal romanzo letterario, lo azzanna al collo e lo lascia esangue in balia di editori che chiedono oramai a tutti, inevitabilmente, ai loro autori libri veloci, non troppo complessi, meglio se elementari, meglio se leggibili fra una salita e una discesa dalla metropolitana o dall’autobus di linea pendolare.
E colpevolmente, a mio modesto parere, le Susanne, gli Alberti, i Fabio, una pletora di ex-magistrati in Italia ― hanno chinato religiosamente la testa e gli hanno consegnato il “prodotto”. Può una industria che sforna 20-30 mila volumi cartacei all’anno, vedere un futuro in digitale? In velocità e in semplicità di trame e di personaggi?
Non vi saprei dire. Però il rapporto fra cinema, poesia, letteratura e immersione tecnologica sta evolvendo molto velocemente. Occorrerebbe una nuova generazione di autori che non sentisse alieno nessuno dei quattro poli che ho appena menzionato. E che quindi sapesse, con maestria, con mestiere, e alla luce del proprio racconto, dosare e domare la materia, articolandola sul proprio crinale narrativo.
Tutti e quattro. Più uno.
Credo che immaginiate a cosa mi riferisca.